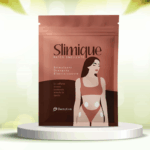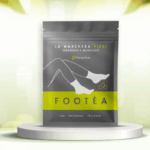La melanina è un pigmento biologico fondamentale la cui funzione primaria è quella di proteggere la pelle dai danni causati dalla radiazione ultravioletta (UV) del sole, determinando al tempo stesso le diverse tonalità di pelle, occhi e capelli negli esseri umani. Tuttavia, la quantità prodotta varia sensibilmente da individuo a individuo, da popolazione a popolazione e risponde a molteplici fattori legati a genetica, ambiente e necessità evolutive.
La produzione di melanina: processi e meccanismi
La sintesi della melanina avviene per mezzo dei melanociti, cellule localizzate principalmente nello strato basale dell’epidermide, ma presenti anche nei bulbi piliferi e in altre sedi, come l’occhio. All’interno dei melanociti sono presenti organuli chiamati melanosomi, deputati alla produzione, stoccaggio e trasferimento della melanina alle cellule circostanti, i cheratinociti, che costituiscono la maggior parte dell’epidermide.
La produzione di questo pigmento, chiamata melanogenesi, comincia a partire dall’amminoacido tirosina. L’ossidazione e la successiva polimerizzazione della tirosina, attraverso una serie di reazioni enzimatiche mediate soprattutto dalla tirosinasi, porta alla formazione dei due principali tipi di melanina: eumelanina (pigmento bruno-nero) e feomelanina (giallo-rossastra). Oltre a queste si identifica la neuromelanina, coinvolta nella colorazione di alcune regioni cerebrali.
È importante sottolineare che, a livello quantitativo, tutti gli esseri umani presentano un numero sostanzialmente simile di melanociti; ciò che determina la diversità dei toni cutanei non è la quantità delle cellule pigmentarie, bensì il numero, le dimensioni, la forma e la dispersione dei melanosomi, nonché la tipologia di melanina principalmente prodotta in ciascun organismo.
Determinanti genetici e regolazione della produzione
Il grado di produzione della melanina è in larga parte regolato dalla genetica. Più specificamente, diverse coppie di geni ereditate dai genitori determinano individualmente e collettivamente la quantità di pigmento che ciascun individuo sarà in grado di produrre nel corso della vita. Tra i principali geni coinvolti emerge il gene MC1R (melanocortin 1 receptor), una componente chiave situata sul cromosoma 16, che regola la risposta dei melanociti ai segnali ormonali e controlla la sintesi e il tipo di melanina prodotta. Varianti specifiche di questo gene spiegano, ad esempio, la tendenza ai capelli rossi e alla pelle molto chiara con elevata sensibilità alle scottature solari.
Oltre al patrimonio genetico, vi sono altri stimoli in grado di modulare la quantità di melanina sintetizzata. Ormoni come l’ormone adrenocorticotropo (ACTH), la lipotropina e soprattutto l’ormone stimolante i melanociti (MSH, Melanocyte-Stimulating Hormone) si legano proprio al recettore MC1R e sono in grado di aumentare la produzione di pigmento. In particolare, l’esposizione ai raggi UV induce la produzione di MSH, favorendo l’abbronzatura come risposta protettiva.
Chi produce più melanina e perché
Il livello di melanina presente nell’organismo umano trova la sua massima variabilità nelle popolazioni distribuite lungo diversi gradienti geografici e climatici. Gli individui con pelle più scura producono quantità più elevate di eumelanina, mentre chi possiede pelle chiara tende ad avere meno eumelanina e una percentuale maggiore di feomelanina.
Questa differenziazione rappresenta il risultato di una lunga adattamento evolutivo alle condizioni di irraggiamento solare. Anticamente, le popolazioni situate in aree equatoriali e tropicali ad alta esposizione UV hanno selezionato geni in grado di aumentare la produzione di melanina scura. Questo pigmento assorbe efficacemente le radiazioni ultraviolette, svolgendo un ruolo protettivo contro i danni al DNA (prevenendo mutazioni e tumori cutanei), e limitando la degradazione di nutrienti essenziali come l’acido folico.
Diversamente, nelle regioni a latitudini elevate dove la luce solare è scarsa, la pressione selettiva ha favorito una ridotta sintesi di melanina per facilitare la penetrazione degli UV attraverso la pelle: così si favorisce la sintesi della vitamina D, indispensabile per il metabolismo del calcio e la salute ossea, la cui carenza diventa problematica dove la sintesi cutanea stimolata dal sole è limitata.
Pertanto, la produzione di melanina risulta più abbondante tra le popolazioni di origini africane, del Sud dell’India, dell’Oceania e di altre regioni con irraggiamento solare intenso. Viceversa, i popoli con origini nordeuropee e dell’Asia orientale tendono ad avere quantità molto più basse.
Altri fattori che influenzano la pigmentazione
Oltre a corredi genetici e climatici, alcune condizioni fisiologiche e patologiche risultano determinanti. Nel corso della vita, l’esposizione al sole induce aumenti temporanei della sintesi di melanina, con fenomeni di abbronzatura che variano in base al fototipo della persona. Anche l’età influisce: macchie cutanee (“lentiggini solari” o “macchie senili”) compaiono frequentemente dopo decenni di stimolazione da parte degli UV.
Vi sono inoltre situazioni in cui la produzione di melanina risulta alterata:
Anche le abitudini individuali e lo stile di vita possono svolgere un certo ruolo. Sebbene la determinazione genetica sia prevalente, esposizione frequente e controllata alla luce solare aumenta la quantità di melanina prodotta, mentre una vita sottoposta a poca luce può ridurne la sintesi, anche nelle popolazioni geneticamente predisposte a produrne di più.
Funzioni biologiche e implicazioni della melanina
Il ruolo della melanina si estende ben oltre quello estetico e protettivo. Oltre a schermare la pelle dai danni dei raggi solari, la melanina contribuisce a:
Al di fuori dei mammiferi, la melanina appare anche in numerosi organismi animali e vegetali, con funzioni di protezione dai raggi solari e dagli agenti esterni, oltre che di mimetismo o attrazione sessuale.
In conclusione, la variabilità nella produzione di melanina rappresenta un eccezionale esempio di adattamento evolutivo umano, fortemente regolato a livello genetico ma dinamico in risposta all’ambiente, all’età e ad altri stimoli biologici. La comprensione di questi meccanismi permette di cogliere a fondo il valore fisiologico della pigmentazione e le ragioni che portano alcune popolazioni, e in minor misura alcuni individui, a produrre decisamente più melanina rispetto ad altri.